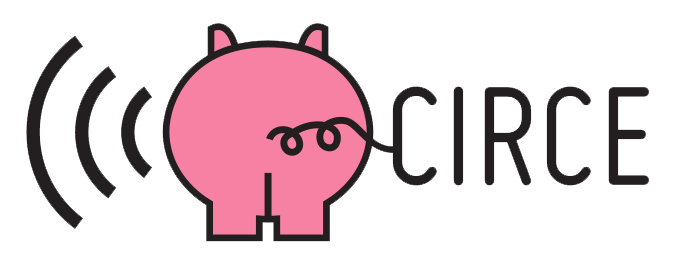Scuola al telefono - Quale miglior momento per insegnare?
Aurora Val, che si occupa di progettazione, comunicazione e storia delle arti, racconta qui la sua esperienza di insegnante durante la pandemia e gli hack ideati per "sopravvivere".
"L’anno scorso sono stata contattata dalla segreteria di un Istituto Afam perché la graduatoria per l’insegnamento alla quale avevo partecipato due anni prima aveva dato i suoi frutti. La materia in questione era Storia della comunicazione e l’inizio delle lezioni era imminente, terza settimana di marzo.
A fronte della sciarada mediatica nella quale stavamo lentamente scivolando, quale miglior momento per insegnare una materia simile?
Firmai il contratto due settimane prima dell’inizio del corso, ma solo qualche giorno dopo mi venne comunicato che non avrei potuto utilizzare altro strumento se non Meet. L’ufficialità delle relazioni tra me e la classe era legittimata dall’utilizzo esclusivo della suite Google e qualsiasi altra forma di interazione non sarebbe stata ritenuta valida.
Il primo aspetto che mi colpì di questo atteggiamento operativo fu la completa mancanza di volontà di discutere modalità d’intervento “alternative”, anche nell’eventualità in cui tali modalità fossero diventate “oggetto” del programma.
Se avessi insegnato una qualsiasi altra materia non afferente l’ambito esteso degli studi “sulla” comunicazione o “intorno” alla comunicazione, avrei probabilmente avuto più difficoltà ad agire nella direzione di una messa in discussione delle modalità di condivisione dei contenuti.
Se “la comunicazione” è l’oggetto di insegnamento, l’atto stesso del mettere in comune contenuti, qui e ora, diventa un potenziale territorio d’indagine.
Lo stato di emergenza ha accentuato la tendenza culturale a considerare i contenuti come qualcosa di separato rispetto alle modalità attraverso le quali li si condivide, sebbene siano le modalità stesse a determinare la qualità dell’apprendimento e la vita dei contenuti all’interno delle nostre vite.
Se, in quanto comunità educante, ci apprestiamo a rinnovare, più o meno consapevolmente, la consuetudine ad attribuire un “primato” ai contenuti rispetto alle modalità di condivisione - come se queste modalità giocassero un ruolo “neutrale” nel rendere i contenuti manifesti - sarà sempre più difficile comprendere il senso che la parola didattica richiama.
La necessità di far fronte all’emergenza da parte dell’Istituto sembrava non lasciare margine di discussione.
Quando la direzione mi ha cortesemente negato ogni genere di negoziazione - rassicurandomi sul fatto che avrei potuto preparare dei powerpoint - ho dovuto mettere il freno a mano alle mie ingenue fantasie di “sperimentazione didattica”.
Emersero una serie di aspetti problematici.
Primo, la quasi totale mancanza di autonomia organizzativa dell’Istituto e la conseguente totale adesione ai non-progetti ministeriali; secondo, la totale mancanza di volontà di discutere di progettazione, in un senso che non prescindesse dal considerare le condizioni di relazione tra le persone come elementi costitutivi del fare progettuale; terzo, ciò accadeva all’interno di un contesto istituzionale orientato all’insegnamento della progettazione della comunicazione; quarto (un problema a tre teste), non avevo mai insegnato a una classe, non avevo mai praticato a distanza, e mai avrei scelto di utilizzare uno qualsiasi dei prodotti Google. Quinto, l’intera gestione delle attività in rete da parte dell’Istituto avveniva tramite Google, e se non avessi accettato le cose come stavano sarei stata sostituita.
Avevo voglia di incontrare quelle persone - la classe; avevo voglia di discutere e interrogarmi insieme a loro su cosa diamine significasse comunicazione date le circostanze e dato lo scenario del momento; avevo necessità di lavorare. Il taglio del programma e della bibliografia erano chiari, ma come fare con Google?
Dedicai il primo giorno di lezione alle presentazioni.
Ventuno persone in tutto, accendevano e spegnevano la telecamera a turno. Raccontai un pò di me, del programma, della bibliografia, e comunicai che dalla volta successiva in avanti le lezioni sarebbero avvenute a schermi spenti. Sarebbe stato come ascoltare la radio o fare telefonate di gruppo. Clubhouse non era ancora in voga e non avevo esempi mainstream ai quali attingere.
I motivi che mi spinsero ad adottare una scelta così unilaterale e un pò estrema erano essenzialmente tre. Primo, quel genere di interazione a schermo provocava in me un profondo disagio. Mai avrei voluto stare a schermo e non volevo costringere loro a farlo. Non era tecnicamente plausibile mantenere ventuno schermi accesi e sincroni per tre ore, ma io ero l’insegnante e secondo una tacita norma dovevo essere visibile e performante. Questo genere di relazione mi sembrava profondamente asimmetrica e sentivo la necessità di trovare una soluzione in cui tutti/e potevamo condividere lo stesso spazio, e quello spazio era lo spazio del suono.
Il secondo motivo che mi spinse in questa direzione era che ritenevo criminale costringere altre persone - più giovani di me e alle quali si supponeva dovessi insegnare qualcosa - a donare la propria faccia a Google.
Se l’insegnamento si basa su un contratto di fiducia reciproca, quel contratto poteva comprendere Google? Era tecnicamente impossibile fidarsi, ed era paradossale essere chiamate e chiamati in quanto docenti, a svolgere, tramite Meet, un corso di formazione per la sicurezza sul luogo di lavoro - quello tridimensionale che non ho avuto occasione di attraversare - malgrado non ci fosse nessuna cura riguardo alla scelta del luogo di lavoro che avremo occupato di lì a un anno.
Il terzo motivo per cui decisi di svolgere lezioni pseudo-radiotelefoniche era che gli studenti e le studentesse trascorrevano fino a otto ore al giorno, da lunedì a venerdì, seduti/e a schermo, e desideravo che in quel tempo assieme potessero assumere una posizione diversa. Che stessero stese sul prato o sul divano, che camminassero, qualsiasi alternativa funzionale a indurre il movimento nei loro corpi era, in quella fase, preferibile. Possibilmente senza l’ansia di dovermi fare entrare in casa.
Una mattina aprii la lezione titubante. Mi ero svegliata di malumore e non riuscivo a capire, negli effetti, che aria tirasse in classe. C’era chi interveniva; chi non faceva mai sentire la propria voce; chi ogni tanto partecipava dando un segnale di vita. Avevo assegnato un’esercitazione e nonostante gli accordi nessuno aveva inviato materiali. Cosa stava stava accadendo alla classe? Chiesi spiegazioni e quando la portavoce del gruppo prese la parola, con l’afflato di chi stava per rivelare un’angoscia trattenuta oltre la calma piatta dei nostri schermi spenti, mi sentii sollevata. Mi chiese(ro) se per cortesia potevo lasciare loro più tempo perché non sapevano come fare. Non ci stavano dentro. Alcune avevano problemi famigliari; molti avevano problemi di connessione. Erano sonoramente stremate/i.
Emerse che non sapevano se e come porre la questione, perché quando tramite le e i rappresentati degli studenti e delle studentesse avevano fatto presente la loro situazione al consiglio docenti, molte delle loro richieste erano state respinte o liquidate come mancanze. Mancanza di volontà, mancanza di disciplina.
Era come se nessuno all’interno dell’Istituzione fosse nella condizione di ascoltare e la sfida era portare a termine il programma come se nulla fosse. Quel nulla erano i nostri corpi.
Qualche lezione prima, mi ero trovata a discutere con loro di tecnologia e della performatività che certi standard comunicativi richiedono. La natura degli argomenti che stavamo trattando, il fatto di rivolgermi a loro chiedendo come stavano o come li facesse sentire parlare di certe questioni, tutti questi aspetti hanno contribuito ad aprire lo spazio ai corpi.
Quando ho imposto la mia regola delle lezioni telefoniche non ero certa di come sarebbero andate le cose. Durante una lezione un ragazzo mi disse che aveva difficoltà perché era abituato a ragionare visivamente e i powerpoint avrebbero fatto comodo. Avevo deciso di non usare powerpoint perché era importante per me che facessero affidamento sul proprio modo di ascoltare e prendere appunti. Non mi interessava che memorizzassero i concetti, mi interessava cosa rimaneva e come rimaneva. Se avessi utilizzato dei powerpoint propinando la sintesi delle mie sintesi, qualcuno avrebbe scritto una parola su un foglio? Non posso saperlo.
Quell’intervento mi offrì l’occasione di argomentare sulla necessità contestuale di allenare altri sensi, il tatto come l’udito, dando spazio all’ascolto. Era la mia versione e desideravo metterla alla prova. Proposi a quel ragazzo di fare di quel disagio il centro della propria riflessione sulla comunicazione. Quel disagio era decisamente interessante e aveva a che vedere con molti degli argomenti in programma.
Al contempo cercavo di essere disponibile. Il programma poteva essere ridotto o esteso in funzione delle necessità del gruppo. Inviavo materiali visivi via mail, spostavo l’attenzione su altri artefatti ed ero aperta a discutere alternative. Gli argomenti del programma e la situazione vissuta si intrecciavano, cautamente, e giorno dopo giorno ci esercitavamo a fare comunicazione.
Quando mi sono chiesta come aggirare Google sono partita dal mio disagio rispetto allo schermo: era mio diritto trovare un modo per stare comoda con le altre persone all’interno della relazione. Non volevo separarmi, non volevo sacrificarmi in-quanto-docente. Cercavo una dimensione condivisa in cui tutt* potessimo trovare un margine di comodità.
Per quanto non seguissi gli schemi della Suite seguivo il mio schema e questa adesione a tratti mi annoiava. Volevo “trasmettere” dei contenuti ma volevo anche introdurre maggiori varianti operative. La creazione di un ambiente di interazione necessita di tempo, pazienza, creatività, fiducia, conoscenze tecniche e strumenti. Uscendo dall’illusione di poter delegare tale lavoro a una Suite sono entrata in contatto con i miei limiti conoscitivi e relazionali.
Dato che non avevano tempo per studiare, proposi di utilizzare delle ore di lezione come momenti di lettura condivisi. Eravamo tutti/e online ma ognuno sui suoi testi, e quando qualcuno voleva condividere qualche pensiero io e le altre persone della classe eravamo lì. Introdurre il silenzio come forma di presenza operativa e condivisa è stato interessante.
Altre ore le utilizzavamo per guardare dei documentari che divennero parte integrante del programma. Non era possibile condividere lo schermo, le connessioni saltavano e chiedere loro di guardarli fuori dall’orario di lezione avrebbe significato costringerl* a trascorrere altre ore a schermo, il che non era auspicabile. Ci incontravamo la mattina su Meet, condividevo il link, e dopo la visione ci ritrovavamo lì per per discuterne.
Non ho mai fatto l’appello sebbene tenessi d’occhio i nomi visibili in lista. Chi mancava o scompariva dalla lista si preoccupava anche di spiegare perché. Ero abbastanza sicura di potermi fidare e più passavano i giorni più avevo voglia di vederli e vederle. Durante le ultime ore di revisione, mentre discutevamo delle bozze inviate in preparazione dell’elaborato finale, ci riappropriammo degli schermi per il gusto di vederci ridere."

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ove non altrimenti specificato